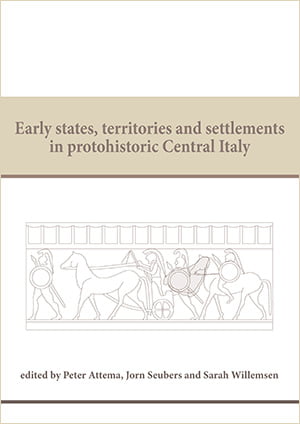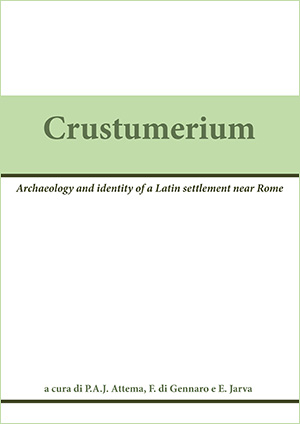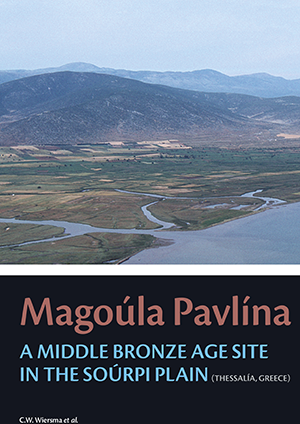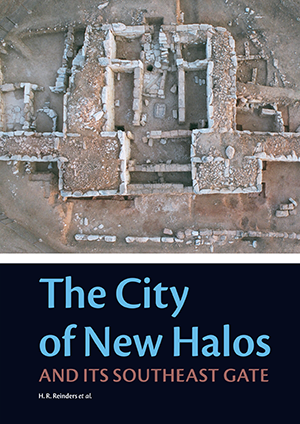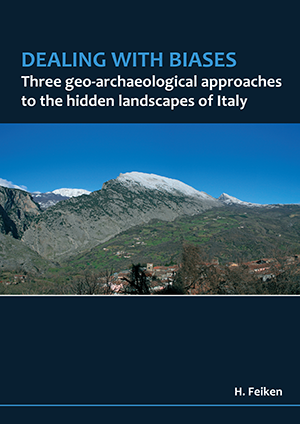Il rilievo montuoso dei Colli Albani, a sud est di Roma, è stato capillarmente indagato sia nel passato sia durante la supervisione scientifica svolta dalle Soprintendenze territoriali in occasione delle moderne attività edilizie. Unendo i dati già noti con i risultati delle recenti campagne archeologiche, è stata sviluppata una ricerca focalizzata sullo specifico aspetto delle vie di comunicazione e sulle dinamiche insediative lungo le pendici occidentali del cratere Albano. La geomorfologia è stata utilizzata come chiave di lettura per comprendere meglio quali fossero le caratteristiche fisiche che più hanno condizionato le varie forme di sfruttamento del territorio. A tal fine, sovrapponendo le evidenze archeologiche così individuate alla carta geomorfologica, le aree intorno alle linee di crinale del cratere sono risultate essere le più ricettive allo sfruttamento e quindi alla modificazione da parte delle comunità. In particolare, i punti di intersezione tra crinali radiali e concentrici al cratere si sono rivelati di maggiore impatto, come descritto nei casi studio individuati in località Marcandreola (Ciampino, Roma). In questi sono emerse successive fasi di sfruttamento della rotta più importante dell’area, su cui si sviluppa la cosiddetta via Castrimeniense, testimonianze di attività vulcanica in età storica e un’intensa attività di culto. L’analisi dei dati ha portato a ridisegnare il graduale sfruttamento di questo territorio prima della sua conquista da parte di Roma.
The Colli Albani is a region close to Rome that has been extensively investigated both in the past and during the scientific supervision of the Superintendency, often preceding modern building activities. Combining data from recent excavation campaigns and legacy data, this research focuses on the specific topics of the communication routes and settlement dynamics on the western slopes of the Alban crater. Geomorphology has been used as a key to better understand the morphological features that most influenced the use of the territory by the human communities. To this end, known archaeological remains were superimposed onto the geomorphological map revealing how human activity is most intense near and on the volcanic ridges. Moreover, the intersections between radial and concentric ridges appear of major importance, as is clear from two cases study sites in the Marcandreola area (Ciampino, Rome). Here, several use-phases of the most important route in the area, as the so-called via Castrimeniense, traces of volcanic activity in historical times, and intensive cult activity, were identified. From this it has been possible to redraw the gradual exploitation of this territory before it was conquered by Rome.
Indice dei capitoli v
Elenco delle illustrazioni vii
Ringraziamenti 1
Introduzione 3
1 Geologia, idrografia e geomorfologia: un approccio metodologico 7
1.1 Introduzione al capitolo 7
1.2 Geologia 9
1.2.1 Le fasi di attività del Vulcano Laziale 9
1.2.2 Attività più recente 9
1.2.3 Idrogeologia 10
1.3 Esempi di opere di ingegneria idraulica 13
1.4 Due differenti scuole di pensiero 15
1.5 Geomorfologia – Crinali, controcrinali, nodi, testate – 22
1.5.1 Crinale di Pratica di Mare 23
1.5.2 Crinale di Roma 23
1.5.3 Crinale di Anzio 24
1.5.4 Crinale di Morena 24
1.6 Osservazioni conclusive al capitolo 25
2 Analisi storico topografica 29
2.1 Introduzione al capitolo 29
2.2 Inquadramento topografico29
2.2.1 Località Sassone 30
2.2.2 Località Marcandreola 31
2.3 Analisi storica 34
2.3.1 Paleolitico 34
2.3.2 Età del Bronzo 35
2.3.3 Cultura laziale- L’età ‘albana’: fasi I – IIA (X – fine del IX secolo a.C.) 36
2.3.4 L’età ‘romulea’: fasi IIB – III (fine IX – fine VIII secolo a.C.) 39
2.3.5 L’età ‘orientalizzante’: fase IV (fine VIII – inizio VI secolo a.C.) 40
2.3.6 Età arcaica e tardo arcaica 41
2.4 Cartografia storica 47
2.4.1 Documenti cartografici dal XVI secolo 47
2.4.2 Osservazioni sulla toponomastica presente in cartografia 52
2.4.3 Documenti cartografici dal XIX secolo 54
2.5 Storia degli studi 57
2.6 Osservazioni conclusive al capitolo 58
3 Il crinale di Roma e la cosiddetta via Castrimeniense/Ferentina 59
3.1 Introduzione al capitolo 59
3.2 I siti lungo il percorso 59
3.3 Schede di sito 92
Siti 94
3.4 Ricostruzione del percorso della Castrimeniense/Ferentina per fasi cronologiche 120
3.5 Osservazioni conclusive al capitolo 120
4 Il sito Marcandreola e la sua contestualizzazione topografica 127
4.1 Introduzione al capitolo 127
4.2 La morfologia dei luoghi 128
4.3 Fase originaria di frequentazione – Tracciato A e B 129
4.3.1 Tracciato A 129
4.3.2 Tracciato B 131
4.4 Fase tardo orientalizzante (IV B)/tardo arcaica (Fine VII inizi V secolo a. C.) 131
4.4.1 Tracciato A 131
4.4.2 Sepolture arcaiche 132
4.4.3 T2: UUSS 91, -92, 93, 99, 104, 114 132
4.4.4 T3: UUSS -122, 123, 124a 132
4.4.5 T4: UUSS 91, -120, 122 134
4.4.6 Tracciato B 134
4.4.7 Fosse 135
4.4.8 Cava 135
4.4.9 Pozzo 4 137
4.4.10 Pozzo 2 137
4.4.11 Elementi arcaici nei depositi votivi 138
4.5 Fase medio repubblicana: IV-III secolo a.C. 139
4.5.1 Depositi votivi 139
4.5.2 Muri a blocchi del tracciato A 140
4.5.3 Abbandono del tracciato A 141
4.6 Fase repubblicana: fine II-I sec. a.C. 142
4.6.1 Muro in opera reticolata 143
4.6.2 Edificio in opera pseudoisodoma di peperino 143
4.6.3 Strada B, fase basolata e sepolture ad incinerazione 143
4.6.4 Villa di Quinto Voconio Pollione, muro di terrazzamento in opera reticolata 145
4.6.5 Manufatti in peperino (elementi architettonici e cippi) 146
4.7 Dalla fine del I sec. a.C. al I sec. d.C. 146
4.7.1 Sistema idrico 146
4.7.2 Piscina trapezoidale 147
4.7.3 Sistema pozzi/condotte ipogee 148
4.7.4 Pozzo 1, UUSS 146, 147 148
4.7.5 Pozzo 3, US 144 149
4.7.6 Pozzo5 150
4.8 Riesame delle principali fasi cronologiche 150
5 Il sito di via Romana Vecchia, sito 22 153
5.1 Introduzione al capitolo 153
5.2 Il sistema pozzi condotte/ipogee 156
5.2.1 Pozzo 1 156
5.2.2 Pozzo 2 157
5.2.3 Condotta ipogea di collegamento 157
5.3 Le murature 159
5.3.1 Fase 1 159
5.3.2 Fase 2, Il monumento funerario 160
5.3.3 Fase 3, le murature USM 153 e il doliarium 160
5.3.4 Fase 4, I pilastri 163
5.4 Necropoli romana esterna all’area dei pilastri 163
5.5 Rioccupazione medioevale 165
5.6 Riepilogo delle fasi di frequentazione del sito 167
5.7 Osservazioni conclusive al capitolo 175
6 Conclusioni 179
6.1 La graduale antropizzazione del territorio – il supporto della geomorfologia 179
6.1.1 Il paesaggio 179
6.2 Applicazione del metodo 181
Indice vii
6.2.1 Dalla via naturale (Ferentina) alla via basolata (Castrimeniense) 182
6.3 La vocazione del territorio 182
6.3.1 La funzione connettiva dell’area di Monte Crescenzio 183
6.3.2 Aree di incrocio 183
6.4 I siti campione 184
6.5 Gestione degli elementi naturali lineari 185
6.6 La lettura del territorio attraverso la viabilità 188
Appendice 191
Barbara Borgers: Ceramic Thin Section Characterisation of Mid-Republican cooking jars from a rural site at Ciampino, Rome 223
Introduction 223
Sample selection and method 223
Results 224
Discussion 225
Bibliografia 231